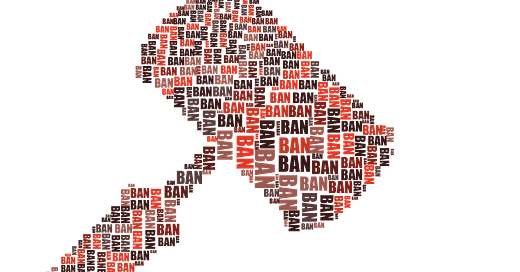Dal politicamente corretto alla cancel culture: una malattia sempre più trasversale
di Sergio Belardinelli (Università di Bologna)
Verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso, la sinistra americana incomincia a distogliere lo sguardo dalle classi sociali più svantaggiate per concentrarsi sempre di più sui diritti civili e la tutela degli interessi di un’ampia varietà di gruppi percepiti come marginalizzati: le donne, i neri, gli immigrati, la comunità Lgbt e simili, avviando una vera e propria battaglia sul linguaggio, nel tentativo di bandire parole che potessero in qualche modo evocare una qualsiasi forma di discriminazione. E’ l’inizio del cosiddetto “politicamente corretto”, un fenomeno culturale che in poco tempo andrà ben oltre l’attenzione all’uso delle parole e alle molestie verbali, radicalizzandosi in forme sempre più illiberali di pratiche identitarie, osteggiate con sarcasmo da destra, che però finiranno per destare non poche preoccupazioni anche a sinistra (cfr. Levitt, Davies, McLaughlin 2000), e che con l’avvento dei social assumeranno una veste sempre più aggressiva e pericolosa: la cosiddetta cancel culture, diffusa ormai non soltanto a sinistra e non soltanto in America.
L’attenzione vessatoria nei confronti di quegli usi linguistici che si ostinano ancora a distinguere tra maschi e femmine, marito e moglie, o che non si preoccupano di occultare il possibile riferimento di certe parole al suprematismo dei bianchi sui neri, dei maschi sulle femmine e cose simili ha generato anzitutto una sorta di “neolingua” in senso orwelliano, poi una serie di pratiche censorie e punitive che hanno poco a che fare con una cultura che voglia dirsi liberale. Statue, quadri, opere letterarie vengono ovunque rimossi o messi all’indice; eminenti uomini politici, filosofi, scrittori, artisti o imprenditori filantropi del passato vengono giudicati secondo un criterio che non si cura minimamente del contesto storico in cui essi sono vissuti, ma si basa soltanto sulla sensibilità morale e culturale di coloro che giudicano. Potremmo anche dire che siamo di fronte all’espressione di una volontà che non riconosce altro limite che se stessa (Belardinelli 2022). Ma quel che è peggio è che questo volontarismo vacuo ha contagiato ormai gran parte della cultura politica americana.
Se a sinistra si agita infatti il fanatismo di questo o quel gruppo che si sente discriminato, a destra, si pensi a Trump, vediamo all’opera un vago patriottismo che non disdegna l’articolazione fanatica dell’interesse nazionale in termini di razza e di religione. In entrambi i casi assistiamo comunque a un uso isterico, vandalico del tema dell’identità. L’appartenenza a un qualsiasi gruppo sembra che non abbia altro collante che la rabbia di chi si sente sotto attacco, offeso, discriminato, e la qual cosa non fa che generare diffidenza, disprezzo, divisioni incolmabili nella società, trasformando il dibattito pubblico in ciò che oltre quarant’anni fa MacIntyre aveva presagito come «guerra civile condotta con altri mezzi» (MacIntyre 1988, p. 302). Come ha scritto Federico Boni, «Se da una parte l’hate speech della destra nelle sue diverse declinazioni della politica pop del web alimenta e rinforza forme di risentimento popolare e di astio verso élite al potere, individuando un “nemico pubblico” su cui peraltro il discorso d’odio ha sempre diretto il proprio rancore (immigrati, omosessuali, disabili e donne), di contro assistiamo al parallelo hate speech della “sinistra di Twitter” individuato da Fisher e Nagle, la cui retorica discorsiva è centrata sulla derisione, l’umiliazione e il disprezzo per gli avversari (della stessa fazione politica come di quella opposta, indifferentemente, considerati come individui scarsamente dotati di capitale culturale (o comunque “non corretto”), e fatti così bersaglio di quella che Bourdieu avrebbe definito come una vera e propria “violenza simbolica”» (Boni 2022, pp. 83-84).
Ma come è potuto accadere tutto questo? Alla radice stanno sicuramente le obiettive discriminazioni di cui nel passato sono rimasti vittime i gruppi sociali di cui si diceva sopra, ai quali la storiografia dedica peraltro sempre maggiore attenzione. Qualche volta magari esagerando, vedi il cosiddetto “1619 Project”, un’iniziativa coordinata da Nikole Hannah-Jones, lanciata nell’agosto del 2019 dal “New York Times Magazine”, con lo scopo addirittura di riscrivere la storia degli Stati Uniti guardando non tanto al 1776, l’anno della Dichiarazione di Indipendenza, quanto piuttosto al 1619, quando sulle coste della Virginia approda la prima nave carica di schiavi. Tuttavia non si può negare l’importanza anche di progetti come questi nel richiamare l’attenzione su fatti per nulla marginali della storia americana (cfr. Cento 2022). Oltretutto, come diceva Walter Benjamin, è sempre opportuno fare il contropelo alla storia, mostrandone il lato oscuro, le ambiguità e le tragedie che spesso si nascondono dietro i suoi monumenti. Ma il fatto è che la cancel culture in genere non si cura delle ambivalenze della storia: si esprime preferibilmente in modo vandalico nei confronti del passato, come se esso potesse essere restituito a una e a una sola dimensione. Una chiusura fanatica e manichea, utile ad eccitare gli animi di coloro che sono «dentro» ma assai lontana dalla realtà e dalla verità.
I principali presupposti di questa chiusura vanno cercati a mio avviso nel clima culturale che verso la fine degli anni Settanta inizio anni Ottanta del secolo scorso venne denunciato da Christopher Lasch come «cultura del narcisismo» (Lasch 1981) e da Alasdair MacIntyre come «emotivismo» morale (MacIntyre 1988, pp. 37-51). Il propellente ideale è rappresentato invece dagli odierni social media, il vero braccio armato della cancel culture. Twitter, per fare un esempio, avrebbe dovuto generare una nuova “piazza”, la piazza digitale appunto, ma persino uno dei suoi fondatori ha dovuto ammettere che non è stato così. Anziché apertura ad altri mondi e ad altre persone, questi media interattivi hanno finito per rafforzare la tendenza a incontrarsi con i propri simili, con coloro che la pensano come noi, trasformandosi in una sorta di «echo chamber», come la chiama Cass Sunstein (Sunstein 2017); una cassa di risonanza che finisce per chiuderci sempre di più nel nostro mondo, precludendoci l’incontro con la diversità, fastidioso quanto si vuole, ma occasione formidabile di crescita, banco di prova insostituibile per le nostre convinzioni e la nostra libertà. E’ ben strano dunque che il mondo virtuale, sebbene produca una diversità di vedute addirittura esorbitante, finisca spesso, da un lato, per essere limitato al mondo che vogliamo, fatto su misura per noi, e per questo molto più omogeneo e accondiscendente di quanto sia quello reale, e dall’altro, per diventare un formidabile strumento per diffondere disprezzo e odio nei confronti di chi non la pensa come noi. La denigrazione dell’avversario è diventata ormai la regola. Ognuno si rinchiude nella sua echo chamber e di lì vengono lanciati improperi d’ogni tipo a chi la pensa diversamente. Basta un tweet e la reputazione di qualcuno può essere rovinata per sempre.
Se il narcisismo, unitamente a crescenti aspettative terapeutiche e a una buona dose di risentimento sono i tratti distintivi delle nostre società; se il sommo criterio di giudizio morale diventa ciò che io sento come buono e giusto; se da un punto di vista sociale conta soprattutto la soddisfazione delle «esigenze emotive» del cittadino/paziente (la medicalizzazione della società, sia detto per inciso, veniva indicato da Lasch come uno dei tratti più preoccupanti della cultura del narcisismo), ovvio che in tale contesto diventi difficile far valere idee universalistiche e interessi generali. Meno ancora se si dispone di una formidabile cassa di risonanza come i nuovi social miranti più al numero dei like che al confronto critico.
Ovunque si diffonde insomma una sorta di emotivismo identitario, che esaspera quello che per me è uno dei principali problemi del nostro tempo: il progressivo accantonamento dell’idea di verità. La validità delle nostre posizioni non dipende più dai buoni argomenti che siamo in grado di addurre in loro favore, quanto piuttosto dai like che esse ricevono sui social.
«Questa atmosfera soffocante finirà per nuocere alle cause più importanti della nostra epoca», scrivono i 150 firmatari della famosa lettera-manifesto contro le pratiche repressive della cancel culture pubblicata il 7 luglio 2020 sulla “Harper’s Magazine” (A letter on justice and open debate). Meglio tardi che mai verrebbe da dire, visto che la maggior parte dei firmatari appartiene alla cosiddetta cultura liberal, per anni invischiata nel narcisismo, nell’emotivismo morale e ammaliata dall’idea della post-truth. Evidentemente ci voleva l’irruzione sulla scena politica di soggetti imprevisti e pericolosi come Trump o Putin, più spregiudicati di altri nell’usare la menzogna, perché incominciassimo a ripensare seriamente la questione della verità. Comunque tanto di guadagnato, se veramente ci stiamo rendendo conto che la libertà e la democrazia hanno bisogno della verità. Accanto al narcisismo e all’emotivismo morale, credo infatti che si debba considerare anche la mancanza di fiducia nella verità tra le cause più importanti del degrado che sta conoscendo il dibattito pubblico nella gran maggioranza dei paesi occidentali. E’ questa sfiducia che in fondo legittima il fanatismo che vediamo all’opera dietro le diverse varianti della cancel culture. E’ sufficiente che io senta o voglia qualcosa, specialmente se anche altri la sentono e la vogliono, perché la qual cosa sia legittima, diventi un diritto da rivendicare, senza preoccuparsi troppo se è ragionevole o meno. Mi rendo conto ovviamente che sto semplificando un problema complicatissimo, ma la cosiddetta politica dell’identità, nelle sue varianti di sinistra e di destra, il più delle volte sembra seguire proprio questa logica.
Per il fatto di vivere in un contesto socio-culturale contrassegnato dalla presenza di diverse opinioni in ordine a ciò che è bene e giusto e di prendere quindi le nostre decisioni politiche a maggioranza, ci siamo erroneamente convinti che un’opinione valga l’altra: siamo diventati relativisti, con la convinzione che questo fosse il modo migliore per essere tolleranti. Ma questo significa soltanto mettere una cattiva filosofia alla base di una pratica eccellente che, alla lunga, potrebbe esserne danneggiata. Le nostre decisioni politiche, ad esempio, vengono prese a maggioranza, non perché una vale l’altra, ma semplicemente perché, grazie a una certa idea che abbiamo dell’uomo, della sua libertà e della sua incommensurabile dignità, è molto meglio una decisione sbagliata, presa con il consenso della maggioranza, che una decisione giusta imposta con la forza (Belardinelli 2018). Altro che relativismo o cancel culture.
Ciò che intendo dire è che, lungi dal costituire il fondamento di una cultura liberale e democratica, l’ostilità alla verità ne costituisce piuttosto la malattia, un habitus mentale che, anziché guardare alla possibilità che le nostre convinzioni etiche, politiche o d’altro tipo vengano validate discorsivamente insieme a coloro che non la pensano come noi, semplicemente le afferma come valide soltanto perché corrispondono al mio modo di «sentire». So bene ovviamente che la discussione razionale è spesso resa difficile dall’oggettiva difficoltà dei problemi che si affrontano. Sono i problemi intricati che il più delle volte ammettono soltanto verità “parziali” o “prospettiche”, addirittura tra di loro incompatibili, come quando diciamo con buoni argomenti che la tal guerra è una sciagura e qualcun altro, con argomenti altrettanto buoni, cerca invece di convincerci che è servita a evitare danni peggiori. Ma questo nulla toglie alla verità. Anzi è proprio in questi casi che più ne avvertiamo l’importanza. È precisamente la coscienza della parzialità dei nostri discorsi a richiedere disponibilità al dialogo, alla comprensione reciproca, alla tolleranza, nella speranza che questa disponibilità ci avvicini ancora di più alla verità. Senza questa fiducia in una verità che in ultimo, con maggiore o minore evidenza, ci si rivela, della quale non siamo padroni, nemmeno i nostri grandi valori politici avrebbero consistenza. Pluralismo, tolleranza, principio di maggioranza, l’idea stessa di stato di diritto e di democrazia finirebbero inevitabilmente per confondersi con la demagogia, la rivendicazione fanatica dei diritti di questo o quel gruppo e la lotta per il potere fine a se stesso. Esattamente quanto si sta verificando nelle nostre società liberaldemocratiche, predisponendo in questo modo una sorta di brodo di coltura ideale per la cancel culture.
Se ne sono resi conto i 150 firmatari, per lo più liberal, della già citata lettera-manifesto pubblicata sulla “Harper’s Magazine”. «Il libero scambio di informazioni e di idee, la linfa vitale di una società liberale – essi scrivono – incontra sempre più limitazioni. Se dalla destra radicale ormai ce lo aspettiamo, l’atteggiamento censorio si sta diffondendo ad ampio raggio anche nella nostra cultura: un’intolleranza verso le opinioni contrarie, la moda della gogna pubblica e dell’ostracismo e la tendenza a dissolvere questioni politiche complesse in una certezza morale accecante».
Premesso che per molti firmatari, visti i loro trascorsi, si potrebbe dire che incominciano a fare la morale dopo aver dato il cattivo esempio, è pur vero che la loro lettera coglie il punto della questione. Non vorrei tuttavia che, dopo aver contribuito ad erodere irresponsabilmente i presupposti che rendono possibile la verità, certa cultura liberal politicamente corretta pretenda di ridarsi un contegno e riaffermare la propria superiorità morale (un vizietto invero assai diffuso a quelle latitudini), facendo della verità il vessillo di una nuova battaglia culturale contro la menzogna e la disinformazione, condotta in modo così radicale da far pensare che abbiano diritto di circolazione soltanto le notizie vere.
Da liberale all’antica, amante della tradizione filosofica classica (Platone e Aristotele, per intenderci), questa idea di verità non mi piace. E non mi piace per almeno due motivi: l’uno, diciamo così, politico, e l’altro filosofico. Il motivo politico mi induce a dire semplicemente che in una società liberale è molto meglio che una bufala possa circolare liberamente, piuttosto che vi sia un ministero della verità che stabilisce quali sono le notizie che hanno diritto di circolazione. Il motivo filosofico riguarda invece l’oggettiva impossibilità che i fatti abbiano una, e una sola, interpretazione vera. Semplifico enormemente, ma come vado dicendo da anni, quando si parla di storia e di notizie che hanno a che fare con i fatti il contrario del vero non è quasi mai il falso, quanto piuttosto la menzogna intenzionale. Per questo c’è bisogno di deontologia professionale da parte di chi i fatti li racconta e un’analoga passione per la verità da parte di chi ascolta o legge, a prescindere che rafforzino o meno le nostre convinzioni o i nostri pregiudizi. Esiste questo ethos nella nostra società? Esistono luoghi – la scuola ma non solo – dove esso possa essere imparato e acquisito? Non mi pare. In ogni caso è questo l’ethos alternativo all’ “atmosfere soffocante” della cancel culture, di cui parlano i firmatari del suddetto manifesto. Si tratta insomma di ricostruire un tessuto, uno sfondo comune, che sottragga la discussione pubblica alla mera volontà dei suoi protagonisti e la riconduca invece ai buoni argomenti – diciamo pure, all’uso della ragione e quindi alla realtà e allo spirito di verità. Speriamo che non sia un programma troppo vasto.
Bibliografia
Belardinelli, S. (2018), L’ordine di Babele. Le culture tra pluralismo e identità, Rubbettino, Soveria Mannelli.
Belardinelli, S. (2022). Cancel Culture: l’identità come volontà senza verità, in “Paradoxa”, n. 2, pp. 25-37.
Boni, F. (2022), Cancellare, con classe. Culture della cancellazione e distinzione sociale, in “Paradoxa”, n. 2, pp. 77-90.
Cento, M. (2022), Passare al contropelo la storia: il mestiere dello storico ai tempi della cancel culture, in “Paradoxa”, n. 2, pp. 39-53.
Lasch, Ch. (1981), La cultura del narcisismo, Bompiani, Milano.
Levitt, C., Davies, S., McLaughlin, N. (2000) (a cura di), Mistake Identities: The Second Wave of Controversy over “Political Correctness”, Peter Lang Inc., New York.
MacIntyre, A. (1988), Dopo la virtù, Feltrinelli, Milano.
Lukianoff, G. (2022), The Second Great Age of Political Correctness, in “Reason Magazine”, gennaio.
Sunstein, C. (2017), #republic. La democrazia nell’epoca dei social media, Il Mulino, Bologna.